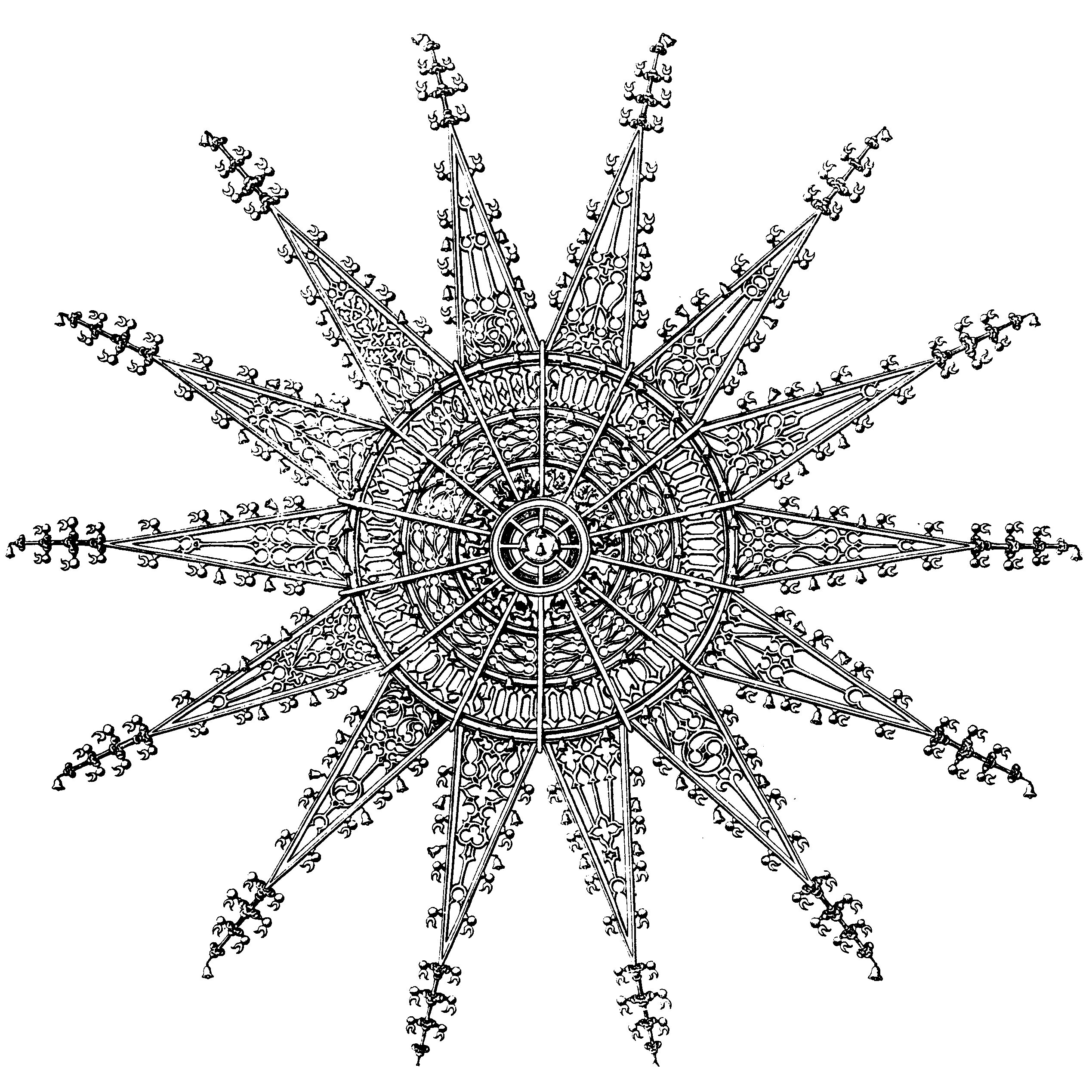Il mese scorso è incominciata la XIII legislatura della Repubblica Italiana. La prospettiva d’una stabilità e durata del parlamento e del governo più lunga che nel passato alimenta le aspettative dei cittadini, in ogni campo della vita civile: anche in quello della musica. La maggioranza parlamentare e l’esecutivo si riconoscono nel programma con cui l’Ulivo ha vinto le elezioni. Nelle lunghe, articolate “tesi” dell’Ulivo la parola musica compare una sola volta, nel paragrafo su «La cultura come risorsa»: «Per quanto riguarda lo Spettacolo, occorrono nuove leggi di settore, laddove non ci sono – teatro, musica -, e la revisione della legge sul cinema…». Nel discorso programmatico di Romano Prodi, presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere (22 maggio) la musica manca del tutto, ovvero s’intende inclusa nelle poche righe globalmente dedicate alla cultura: «È poi per la cultura, nel senso più ampio, che noi dobbiamo impegnarci di più. … Certo, un Governo non ha una cultura da imporre o da promuovere, mentre deve essere un catalizzatore e un garante perché le espressioni più diverse del pensiero e delle arti possano essere favorite e diffuse. È difficile definire la cultura, ma certamente essa è ricerca di espressioni che manifestano la creatività del singolo e quella di un intero Paese».
Perché non sembrino evasivi, riferimenti tanto esigui e generici vanno letti nel loro contesto. Tutto il programma dell’Ulivo insiste sull’idea dello “stato leggero”, lo stato delle regole, «non intrusivo ma intelligente», che nel libero mercato interviene come arbitro e non come giocatore, e si prefigge dunque non di dettare indirizzi ma di esercitare una funzione moderatrice nella società. Esso punta anche sul decentramento dallo Stato verso le Regioni e le autonomie locali, e questo riequilibrio – dal quale peraltro è esclusa la tutela e conservazione dei beni culturali – investirà anche «la produzione, promozione e distribuzione delle attività culturali» (musica inclusa, s’immagina). Infine, il programma dell’Ulivo e del governo enfatizza al maggior segno – la cosa è d’ottimo auspicio – un fattore primario nella dinamica culturale del Paese, ossia la scuola (che è «base di ogni ricchezza»), la formazione professionale, l’università, la ricerca: anche qui s’immagina tacitamente inclusa la musica.
Resta che per ora la ‘voce’ musica è una rubrica bianca, nell’agenda del governo e del parlamento. È d’altra parte vero che «nella sua struttura, e nella distribuzione delle deleghe, questo Governo ha già dato un segnale» su come intende «impegnarsi di più» per la cultura: Prodi allude all’attribuzione ad interim del Dipartimento dello Spettacolo – ciò che resta del vecchio Ministero del Turismo e dello Spettacolo – al ministro per i Beni culturali (Walter Veltroni), e del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica al ministro della Pubblica Istruzione (Luigi Berlinguer). In termini puramente descrittivi, si tratta d’un passo avanti e uno indietro: una spinta verso il futuro Ministero per la Cultura, desiderato da alcuni (soprattutto nel mondo dell’editoria e dello spettacolo, ossia della cultura intesa come invenzione e comunicazione) ed avversato da altri (soprattutto nella sfera della storia dell’arte e della biblioteconomia, ossia della cultura intesa come tutela e conoscenza del patrimonio artistico materiale); e un ritorno alla situazione di prima del 1987, quando l’istruzione universitaria era soltanto un settore entro il più mastodontico dei ministeri, quello appunto della Pubblica Istruzione. Il tempo dirà se l’accorpamento potrà “alleggerire” lo Stato e arrecare buoni frutti. Ciò che si apprezza fin d’ora è l’ambizione d’instaurare un’ottica d’insieme nel governo della cultura, dominio complesso, delicato e, dice Prodi, «difficile da definire»: se anche producesse nulla più che il coordinamento e la concertazione finora ostacolati dalla separatezza dei diversi ministeri, sarà stata un’iniziativa provvida.
Intanto il governo ha già dimostrato di volersi e sapersi adoperare per la musica. È stata trasmessa pochi giorni fa alle commissioni parlamentari una versione riveduta del decreto legislativo che trasforma in fondazioni a gestione privatistica gli Enti lirici e i Teatri di tradizione. Dopo le aspre critiche suscitate dal precedente decreto del governo Dini (16 maggio 1996), il ministro Veltroni ha raccolto il plauso corale di sovrintendenti e sindacati attenuando sia certe fatali disparità nelle chances dei teatri interessati dal decreto, sia l’incubo dello sfoltimento degli organici. Il finanziamento privato – entro limiti definiti e con ben calibrati poteri d’incidenza sulle scelte artistiche – fa il suo ingresso negli enti che “conservano” il patrimonio musicale più acclamato della nazione, l’opera lirica. Con tale liberalizzazione economica, le ragioni del management, incarnate nella figura del sovrintendente, vengono a preponderare sulle ragioni dei programmi artistici e culturali: si fa un altro passo, e decisivo, in senso opposto a quello del direttore di teatro di tipo tedesco, ossia del musicista ch’è nel contempo direttore artistico e manager. E per ovviare alla diarchia imperfetta sancita dalla legge Corona del 1967 si declassa d’un altro gradino il direttore artistico, nominato non più dal consiglio d’amministrazione ma direttamente dal sovrintendente, del quale finisce per essere un collaboratore subalterno. Gli anni a venire diranno se il sistema dei manager darà buona prova. Per ora si può osservare che l’assioma della «cultura come impresa», oggi tanto in auge, ha fatto aggio sul secondo termine della diade più che sul primo. Si osserva anche che, in un Paese che vanta severissimi concorsi per l’assunzione al ruolo di sovrintendente alle Belle Arti, e a fronte d’un programma di governo che vuole «intervenire sulla riorganizzazione dei percorsi formativi e professionali», la figura professionale del sovrintendente nei teatri d’opera viene definita in base alla mera competenza di fatto: «Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente»; è come dire che saranno gli stessi sovrintendenti a selezionare a discrezione e a formare sul campo, a propria immagine e somiglianza, le nuove leve e i potenziali successori. Il che, nella perdurante assenza di curricula universitari specifici, non stupisce neppur tanto: dell’unica proposta d’un corso di diploma per Operatori musicali all’esame del Ministero dell’Università si dice da anni che è in dirittura d’arrivo, che è sul tavolo del ministro per la firma, ma la firma finora non c’è. Ecco un caso in cui il coordinamento tra i ministeri potrebbe giovare.
Il decreto sui teatri d’opera dimostra che il governo in carica sa agire con determinazione in campo culturale (e confidiamo che il Parlamento conforterà tale impressione), ma conferma anche che in Italia la cultura musicale è subalterna: in questo caso alla cultura dell’impresa e dell’azienda, come in altri casi lo è alla cultura filosofica, letteraria, storica, figurativa. Non è un mistero, anzi è una realtà storica conclamata nell’Italia moderna e contemporanea, che il musicista vive una separatezza culturale al tempo stesso orgogliosa e depressiva, e che la musica è a malapena riconosciuta come attività intellettuale dalla stessa classe dei colti. È bensì vero che il potere politico e la società civile da sempre considerano la musica una professione socialmente utile, ma è anche vero che la concepiscono piuttosto alla stregua d’un esercizio artigianale affidato a una categoria di esperti che non d’un sapere diffuso condiviso dalla collettività. Il sapere musicale – un sapere in parte molto tecnico – è in Italia un sapere corporativo, che penetra poco nella coscienza culturale della società, per l’effetto congiunto della sua scarsa “necessità” materiale e della diffidenza che una cultura di matrice idealistica ha tradizionalmente nutrito verso un linguaggio difficile da verbalizzare e verso una teoria che agli estranei appare arcana. L’analfabetismo musicale è da noi una realtà troppo nota per doverla richiamare qui.
Ciò che l’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale” si sente di fare è sottoporre al Governo e al Parlamento un promemoria dei cinque o sei provvedimenti che conviene varare in questa legislatura per dare alla cultura musicale nel Paese un più saldo fondamento e un più robusto tessuto. Sono provvedimenti nel complesso poco o nulla costosi, e mirano al beneficio della musica nell’interesse della collettività, non alla difesa di privilegi professionali o di categoria. Sappiamo che il presidente del Consiglio proviene da una famiglia dedita – caso piuttosto raro in Italia – al culto amatoriale della musica da camera: siamo certi ch’egli saprà cogliere l’intenzione di questi appunti ed appropriarsene nell’azione di governo. Confidiamo che lo stesso valga per i due ministri interessati, per i presidenti delle due Camere, per i presidenti e membri delle commissioni Cultura (Camera) e Pubblica Istruzione (Senato), per i dirigenti e funzionari delle amministrazioni ministeriali. Sono appunti che rasentano l’ovvietà: non prendono partito per una soluzione o per l’altra, si limitano ad additare problemi che sono sotto gli occhi di tutti. I primi tre riguardano principalmente la sfera dell’istruzione, gli altri la sfera dei beni culturali.
(1) L’istruzione musicale nella Scuola secondaria superiore. – Se il livello dell’alfabetizzazione musicale diffusa si è elevato d’un poco negli ultimi decenni, lo si deve innanzitutto all’estensione dell’educazione musicale a tutta la scuola dell’obbligo (1963). Essendo finora mancata la riforma della scuola secondaria superiore, la felice innovazione è rimasta in tronco: assunti i primi rudimenti nella scuola elementare e media, lo studente liceale dismette ogni rapporto didatticamente mediato col mondo della musica; la sua cultura musicale viene abbandonata all’iniziativa della famiglia (alla pesante doppia scolarità liceo/conservatorio, all’insegnamento privato d’uno strumento), o all’offerta indiscriminata dei mass media. Tra storia della cultura – storia politica, letteraria, filosofica – e storia della musica s’interrompe, all’età di quattordici anni, ogni circuito. Tale divorzio è tanto più paradossale se si pensa che la cultura giovanile d’oggi è imbevuta come mai prima d’ora di musica: di musica di consumo.
Da qualche tempo va per la maggiore il richiamo all’ordine: la scuola non si disperda in mille rivoli, torni a far quadrato sulle materie “forti”. A costo di remare contro l’onda, abbiamo la presunzione di ritenere che la cultura musicale sia necessaria alla formazione del cittadino, e che perciò vada introdotta nei programmi dei licei. Sul tema dell’istruzione musicale nella scuola secondaria superiore “Il Saggiatore musicale” si è già pronunciato due volte: con un’inchiesta critica sui programmi di musica elaborati dalla commissione Brocca per il biennio e il triennio (nell’annata I, 1994, pp. 377-391), e con una giornata di studio apposita (Bologna, 11 maggio 1996). Da quest’ultima iniziativa, apprezzata anche dalla stampa quotidiana meno disattenta (cfr. «La Stampa», 30 maggio 1996), è scaturito un documento collegiale, che pubblichiamo in appendice a questo intervento; lo stesso gruppo di lavoro composto da musicologi e pedagogisti sta elaborando la revisione dei programmi Brocca (pregevoli nell’insieme, ma infelicissimi proprio nel caso della musica), da proporre all’attenzione del ministro, degli esperti e dell’opinione pubblica.
L’introduzione della cultura musicale nei licei comporta di necessità che le discipline musicali vengano incluse negli istituendi corsi universitari di specializzazione abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria (legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 4).
(2) I Conservatorii. – Nella passata legislatura la commissione Cultura del Parlamento ha elaborato un progetto di legge-delega per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatorii di musica e del Centro sperimentale di cinematografia (il cosiddetto testo unificato Sbarbati, 13 settembre 1995). La legge-delega configura degli Istituti Superiori delle Arti di grado universitario: essi passerebbero al Ministero dell’Università; si costituirebbe, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio Universitario Nazionale, un «organo di alta consulenza» denominato Consiglio Nazionale delle Arti; norme idoneative regolerebbero il passaggio agli ISdA del personale oggi in servizio nei Conservatorii; gli studi musicali di grado inferiore verrebbero riordinati in Scuole medie ad orientamento musicale e in Conservatorii di base (quinquennali). Dopo aver raccolto dapprima un certo consenso presso i docenti degli attuali Conservatorii, alimentato dall’euforica illusione di un’equiparazione indiscriminata alle Università, nella fase finale dell’iter legislativo il progetto è stato subissato dagli emendamenti incrociati e, nell’opinione pubblica, dalle polemiche contrapposte. Tutti sanno che l’ordinamento dei Conservatorii, risalente al 1918-1930, va riformato, così come vanno aggiornati i programmi e adeguati alle nuove figure professionali i curricula: ma si paventa che la riforma Sbarbati disperda in un sol colpo alcuni pregi storici dei Conservatorii italiani, in particolare la continuità didattica che, per certe discipline (strumenti, canto), consente di seguire l’alunno sull’arco di otto-dieci anni; si teme anche che la spartizione tra due ministeri (Pubblica Istruzione per i livelli inferiori, Università e Ricerca per il livello superiore) determini scoordinamento ed emargini viepiù l’istruzione musicale, che verrebbe a cadere – come dicono i tedeschi – zwischen zwei Stühlen. Ora l’attribuzione dei due Ministeri ad un unico ministro apre prospettive potenzialmente più fauste.
Sembra ragionevole mantenere, ammodernandolo, l’ordinamento “lungo” e continuo dei Conservatorii; è indispensabile configurare agganci flessibili con le scuole medie e i licei, per agevolare la cultura musicale diffusa: nella società odierna i Conservatorii non sono più soltanto una scuola per apprendisti professionisti. Va ripensata la loro funzione di scuole esclusivamente finalizzate alla formazione di personale da destinare al mondo del lavoro. È evidente a tutti che le nostre strutture musicali – orchestre, cori, teatri – non sono affatto in grado di assorbire i diplomati degli oltre sessanta Conservatorii attuali; né esistono le risorse economiche per ampliare le strutture di produzione in misura tale da offrire un impiego ai musicisti in cerca d’occupazione. D’altro canto i Conservatorii sono frequentati da un pubblico enorme e ormai indifferenziato di studenti – molti non hanno né le capacità né l’ambizione di dedicarsi alla professione – ma non sono in grado di fornire a tutti gli alunni un’istruzione musicale d’alto livello e competitiva su un mercato del lavoro che s’è aperto alla concorrenza europea.
L’auspicata riforma ha dunque due strade davanti a sé. O si riduce il numero dei Conservatorii e nel contempo se ne riqualifica la didattica, in una politica programmata e coordinata con quella delle strutture di produzione – la qual cosa esige un’efficace concertazione tra i ministeri interessati -, e si trasformano gli istituti in eccesso in scuole musicali non professionali (magari collegate alla scuola dell’obbligo e alla secondaria). O si differenzia entro ciascun Conservatorio una fascia specialistica e una fascia destinata a fornire una seria cultura musicale amatoriale.
Ciò non preclude, anzi suggerisce l’istituzione di un certo numero di Accademie musicali integrate nel sistema universitario, alla stregua delle Musikhochschulen tedesche, austriache e svizzere. Integrate: con tutto ciò che ne consegue. Un unico organo superiore di consulenza (il Consiglio Universitario Nazionale, che già esiste, non un CUN parallelo – il ventilato Consiglio Nazionale delle Arti – che sancirebbe una volta di più la segregazione della musica rispetto alle altre discipline). Dipartimenti universitari congiunti (come in Germania, come negli USA). Carriere uniche, e accessi per concorso (niente sanatorie).
Visto che l’Università è la sede primaria della ricerca, occorrerà uno sforzo d’immaginazione per definire cosa sia la ‘ricerca’ in musica: la questione è chiara per la musicologia in tutte le sue diramazioni (compresa la didattica della musica), lo è anche per la composizione e la teoria musicale (finalmente i nostri compositori potrebbero disporre di quelle risorse e agevolazioni che oggi sono date ai loro colleghi statunitensi o tedeschi: fondi di ricerca per acquisto di bibliografia e attrezzature, per seminari e convegni, anni sabbatici, soggiorni all’estero ecc.), lo è un po’ di meno per le classi di direzione, strumenti e canto. Ma non mancano i termini di paragone coi paesi stranieri.
(3) L’Università. – La legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (n. 341 del 19 novembre 1990) ha innescato un processo accelerato e a volte tumultuoso di rinnovamento. La proliferazione dei corsi di studio e relativi titoli – alla vecchia laurea e al dottorato di ricerca istituito nel 1980 si aggiungono il diploma universitario (la “laurea breve”) e l’istituendo diploma di specializzazione post-laurea, che abiliterà all’insegnamento nelle scuole secondarie – è venuta a coincidere con una fase di ristagno e anzi di contrazione della docenza, con tutte le asperità e i conflitti che ne derivano. In questo processo di riforma, il valore legale dei titoli di studio – una specialità tutta italiana – è una vera e propria camicia di forza: da un lato, il centro (il Ministero, il CUN) è costretto a dettare norme vincolanti per tutti e ad esercitare un controllo occhiuto su una realtà periferica tanto frastagliata da sfuggirgli (i più di sessanta Atenei statali e privati, le centinaia e centinaia di Facoltà); dall’altro, i docenti di tutt’Italia sono assorbiti in una perpetua negoziazione dentro gli organi accademici e nei confronti del Ministero, nell’illusione che a certi rebus esistano soluzioni buone per l’Università di Trento come per quella di Lecce, per la Facoltà d’Agraria come per la Scuola di Studi Islamici. La necessità di dettare norme universalmente valide impone provvedimenti sconosciuti agli altri sistemi universitari europei, quale ad esempio la definizione per legge delle discipline ufficialmente riconosciute, raggruppate nei cosiddetti “settori scientifico-disciplinari”. I rischi che ne derivano sono ben esemplificati dai settori scientifico-disciplinari di musica (L27A, L27B, L27C), disegnati dagli organi ministeriali in maniera così caotica e lacunosa da aver indotto il CUN a riformularli ex novo: ma a tutt’oggi le rettifiche CUN del 19 maggio e 16 giugno 1995 non sono state deliberate dal Consiglio dei Ministri, sicché nei prossimi concorsi universitari succederà che commissari specialisti di musica medievale o di etnomusicologia giudicheranno candidati a posti di musica contemporanea, e viceversa.
La posizione dell’Ulivo sul valore legale non è chiara: le “tesi” dicono unicamente che «bisogna intervenire sugli ordinamenti didattici e la riorganizzazione dei percorsi formativi e professionali (anche in relazione al valore legale dei titoli di studio)». Se si abolirà il valore legale, ne guadagnerà l’autonomia e la flessibilità, si darà slancio alla competizione tra gli Atenei desiderosi d’assicurare un elevato standard ai propri corsi di studio. Se non lo si può o non lo si vuole abolire, si provveda almeno a cancellare la finzione illuministica dell’unico titolo di studio, il Dottorato di ricerca, che per legge ne è privo: al momento attuale, proprio i giovani studiosi più lungamente addestrati nelle nostre Università – con borse a carico del pubblico erario – sono tagliati fuori da certi concorsi pubblici. È macroscopico il caso dei Dottori di ricerca in discipline musicali, quasi sistematicamente esclusi dalle classi di Storia della musica nelle graduatorie dei Conservatorii (cfr. «Il Saggiatore musicale», I, 1994, pp. 197-207: 200 sg. ): anche qui, l’unificazione al vertice dei due Ministeri interessati – Università e Pubblica Istruzione – è potenzialmente propizia ad un miglior coordinamento.
Nell’evoluzione indotta dalla legge n. 341 il destino delle discipline musicali appare fragile, per un doppio ordine di motivi. Da un lato, l’art. 9 prescrive per le nuove “tabelle” – gli ordinamenti dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione – un’»omogeneità disciplinare» che ne accentua il carattere specialistico. È esemplare la revisione della tabella di Lettere, ossia del corso di laurea che storicamente è l’alveo primario degli studi di musicologia nell’Università italiana: le discipline musicali non vi sono contemplate tra le caratterizzanti, neppure a titolo opzionale (mentre lo sono l’archeologia e la storia dell’arte, in ossequio ad una tradizione tanto illustre quanto vetusta, che però oggi non giustifica più alcuna preminenza rispetto alla musica). Si trascura il generale valore formativo della cultura musicale; si ribadisce l’estraneità della musica alla cultura filologico-letteraria (anche se poi tutti riconoscono i nessi che corrono tra poesia e musica nella storia letteraria d’Italia); s’immagina un laureato in Lettere che, senza essersi dissipato in troppe discipline “superflue”, acceda ai futuri corsi di specializzazione per poi sboccare come docente in un liceo privo di qualsiasi insegnamento musicale. Tout se tient. La musica rimanga ai tecnici.
Dall’altro lato, alla specializzazione assai accentuata di altri corsi di studio – in primis i corsi di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, in Musicologia, in Conservazione dei Beni culturali (con indirizzo Beni musicali) – non corrispondono sbocchi professionali definiti. Per un verso si concentra lo studio della musicologia in pochi corsi universitari (magari sovraffollati come il DAMS di Bologna), ma se ne vanifica poi la specificità all’atto dell’inserimento nel mondo del lavoro e segnatamente nella pubblica amministrazione. È un punto su cui può e deve esercitarsi l’oculata «riorganizzazione dei percorsi formativi e professionali» prospettata dall’Ulivo. Ora sarà più facile per il ministro dell’Università concertare col Ministero della Pubblica Istruzione la disciplina dei titoli di studio per l’insegnamento nelle scuole e nei Conservatorii – la normativa vigente è disordinata, a tratti selvaggia -, mentre col ministro per i Beni Culturali, delegato per lo Spettacolo, dovrà negoziare gli sbocchi nell’amministrazione dei beni culturali (musei, sovrintendenze, biblioteche e discoteche: i corsi in Conservazione dei Beni culturali, istituiti con tanto fervore pubblicitario e tanto dispendio per lo Stato, sfornano diplomati e laureati che non hanno per ora accesso al governo dei beni culturali medesimi) e nella gestione degli Enti lirici e dei teatri (dove finora le nomine degli addetti alle direzioni artistiche e agli uffici stampa non sono state regolate da alcuna disciplina che non fosse la convenienza – in senso lato politica – delle sovrintendenze). Per quest’ultimo settore, si richiama qui quel che s’è già detto: s’istituisca finalmente la “laurea breve” per Operatori musicali.
(4) La musica come “bene culturale“. – Una premessa. Il concetto stesso di ‘bene culturale’ è difficile da definire in musica. Il problema è d’ordine estetico. Se il quadro, la statua, il monumento architettonico esauriscono in sé tutta l’opera d’arte, se il manoscritto autografo o l’edizione critica preservano definitivamente il testo del poema o del romanzo, lo stesso non può dirsi dell’opera d’arte musicale. Anche in musica esistono oggetti materiali inventariabili, partiture (ossia libri manoscritti o a stampa, da conservare alla stessa stregua degli altri libri), strumenti (ossia pezzi d’artigianato e di mobilio), testimonianze iconografiche (ossia dipinti), teatri storici (ossia edifici monumentali), documenti d’archivio cartacei e sonori. Ma questi oggetti non sono mai tutta l’opera d’arte musicale: che sta altrove, fuori da essi ancorché collegata con essi, che va ricreata e interpretata, che non ha consistenza oggettiva. Il “patrimonio musicale” è qualcosa che il codice civile farebbe fatica a definire. È una catena di tre cose insieme. Un patrimonio materiale da conservare: come tale sta nelle biblioteche (generiche o specializzate), nei musei, negli archivi, nelle discoteche, nelle nastroteche. Un patrimonio ideale da conoscere studiare pubblicare tramandare: come tale dà luogo a ricerche, ad edizioni, a studi, a tradizioni didattiche, a “restauri” di prassi esecutive, sta dunque nelle scuole nei conservatorii negli enti di ricerca. Un patrimonio da godere – altri direbbe da consumare – trasformato in evento e in comunicazione: come tale sta nei teatri, nelle sale da concerto, nei media. La cultura musicale ha una struttura diffusa, o trasversale, o stellare: è un tessuto fatto di messaggi che non si riducono mai del tutto né al solo oggetto (come invece i dipinti) né al solo testo (come invece la letteratura) né al solo spettacolo (come invece il teatro o il cinema). In un Ministero per la Cultura la musica non si lascerebbe sussumere in un’unica Divisione, in un unico Ufficio centrale, neppure in un’unica Direzione generale: starebbe per forza un po’ di qua e un po’ di là, un po’ sotto l’etichetta dei ‘beni culturali’ e un po’ sotto l’etichetta dello ‘spettacolo’, col solito, eterno rischio di cadere tra due sedie, di venir palleggiata da un settore all’altro. Se il ministro vorrà istituire un organo apposito per “la” musica, tenga conto della sua natura molteplice e proteiforme; se preferirà lasciarla dissolta nelle varie ripartizioni del suo Ministero-e-Dipartimento, crei nondimeno i raccordi necessari. Eviti anche che il fascino promanante dalla musica come evento e spettacolo monopolizzi gli sforzi del governo e di riflesso atrofizzi la tutela del patrimonio materiale e del patrimonio ideale.
«È straordinario pensare che il 60% di tutte le opere artistiche del mondo siano nel nostro Paese», ha detto Prodi. Noi non sappiamo se sia più o meno del 60% il patrimonio di partiture manoscritte, edizioni rare, strumenti antichi, teatri storici, dischi e nastri posseduto dal Paese: sappiamo che è ingentissimo, non sempre ben conosciuto e custodito, talvolta poco o nulla accessibile. Sappiamo anche che, per la sua natura poco appariscente, è un patrimonio che non si presta gran che al tipo di sfruttamento commerciale e divulgativo che può invece dare cospicui introiti ai musei delle arti figurative. Bisogna esserne consapevoli.
(5) Le biblioteche storiche dei Conservatorii. – L’anomalia più vistosa, nel settore dei beni musicali, è quella dei nuclei storici nelle biblioteche di Conservatorio. Le quali sono biblioteche scolastiche, aperte di diritto agli studenti e ai docenti della rispettiva scuola, e solo di fatto – se il bibliotecario lo consente – agli studiosi esterni. Fondi librari di valore immenso possono venir sottratti alla consultazione sol perché ubicati in biblioteche pubbliche sì, ma concepite in funzione dell’insegnamento scolastico. (La situazione non muterebbe radicalmente negli Istituti Superiori delle Arti secondo la riforma Sbarbati: da scolastiche che sono, diventerebbero biblioteche di dipartimenti universitari, con vincoli analoghi.) L’anomalia sta, ancora una volta, nel doppio regime, nello iato tra cultura e musica: il manoscritto letterario o giuridico o filosofico sta in una biblioteca statale, e questa ha il compito primario di conservarlo, custodirlo e renderlo accessibile agli studiosi; il manoscritto musicale sta in una biblioteca scolastica, ma questa ha il compito precipuo di fornire i manuali e gli spartiti per l’insegnamento corrente, non di custodire cimeli.
Molte soluzioni sono state prospettate nei due decenni scorsi, dentro e fuori del Parlamento, per ovviare ad uno stato di cose che tutti, addetti come utenti, riconoscono inadeguato: nessuna ha incontrato il plauso e lo slancio necessari per giungere in porto. “Il Saggiatore musicale” ritiene che, in uno stato ideale, competerebbe ai Beni culturali più che alla Pubblica Istruzione il governo di fondi storici preziosissimi – e sostanzialmente inutili all’insegnamento scolastico – come quelli posseduti dai Conservatorii di Milano, Genova, Padova, Venezia, Pesaro, Firenze, Roma, Napoli e Palermo: ma qualsiasi altra soluzione ragionevole sarà preferibile all’inerzia e alla stagnazione, soprattutto in presenza di casi macroscopici e scandalosi (eppur perfettamente legali) come la chiusura, da anni, delle biblioteche musicali di Napoli e di Firenze. Va detto che, se nonostante tutto in questi anni alcune biblioteche di conservatorio hanno assicurato un servizio dignitoso, lo si deve in gran parte alla dedizione e allo zelo ammirevole di singoli bibliotecari.
(6) Il bibliotecario e l’archivista musicali. – Nella passata legislatura la Camera ha elaborato una proposta di legge (n. 2109, 28 febbraio 1995), poi caduta, per l’ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell’arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario. Prevedeva l’istituzione di appositi ordini e albi professionali. È auspicabile che venga ripresa nella XIII legislatura. Ma è indispensabile che venga estesa fino a definire giuridicamente certe figure professionali di esperti dei beni culturali musicali. Una certa qual coerenza analogica vorrebbe che la serie ‘archeologo – storico dell’arte – archivista – bibliotecario’ venisse semplicemente continuata aggiungendovi la categoria del ‘musicologo’ tout court. Si avrebbe così, se non altro, una perfetta simmetria e corrispondenza con gli indirizzi in cui è articolato il corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali. Ma è chiaro che si ripresenterebbe il problema, già menzionato, dell’eterogeneità degli oggetti materiali che costituiscono i beni musicali, dai rotuli degli Exultet ai dischi 78 giri, dal flauto d’osso alle videocassette, dalla muta di madrigali cinquecenteschi ai bozzetti scenici del melodramma, dall’archivio d’una cappella ecclesiastica al pianoforte ottocentesco.
Una soluzione minima, un compromesso ragionevole potrà contemplare la specializzazione musicale almeno delle qualifiche di archivista e di bibliotecario. Prendiamo quest’ultimo. Al momento la figura del bibliotecario musicale non esiste (se non come classe di concorso nei Conservatorii); i pochissimi bibliotecari nelle biblioteche statali dotati d’una preparazione e d’un titolo di studio specifici, e addetti alla custodia di collezioni musicali di straordinario pregio (p. es. a Torino, a Modena, a Firenze, alla Casanatense), sono entrati nei ruoli più per felici congiunture individuali che per un disegno coerente di programmazione delle competenze, e nulla assicura che nel turnover vengano sostituiti da personale altrettanto competente.
Per porre rimedio a questo stato di cose è necessario che la nuova legge armonizzi a vicenda la disciplina dei titoli d’accesso (art. 17) e la realtà degli studi universitari. Secondo il dettato della proposta di legge del 1995, nessun corso di laurea – neanche quello in Conservazione dei Beni culturali, indirizzo Beni musicali – consentirebbe ad un giovane musicologo particolarmente versato nel campo della bibliografia e biblioteconomia musicale di presentarsi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di bibliotecario. Per converso, non risulta che l’indirizzo archivistico e librario dello stesso corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali – canale preferenziale nella proposta di legge – dia la benché minima garanzia di competenza bibliografico-musicale. Un’estensione analoga andrà contemplata per la figura dell’archivista musicale, inteso come curatori di archivi sia cartacei sia sonori. Se tale limitazione dei titoli d’accesso e tale esclusione di profili perfettamente assimilabili come quelli del bibliotecario e dell’archivista musicale verranno mantenute nella rinnovata proposta di legge, s’avrà l’amara conferma che, scientemente o no, il Parlamento avalla – ancora una volta – la spaccatura che in Italia tiene separate la musica e la cultura.
Ma “Il Saggiatore musicale” ha motivo di confidare che questo Governo, questo Parlamento segneranno un punto di svolta.