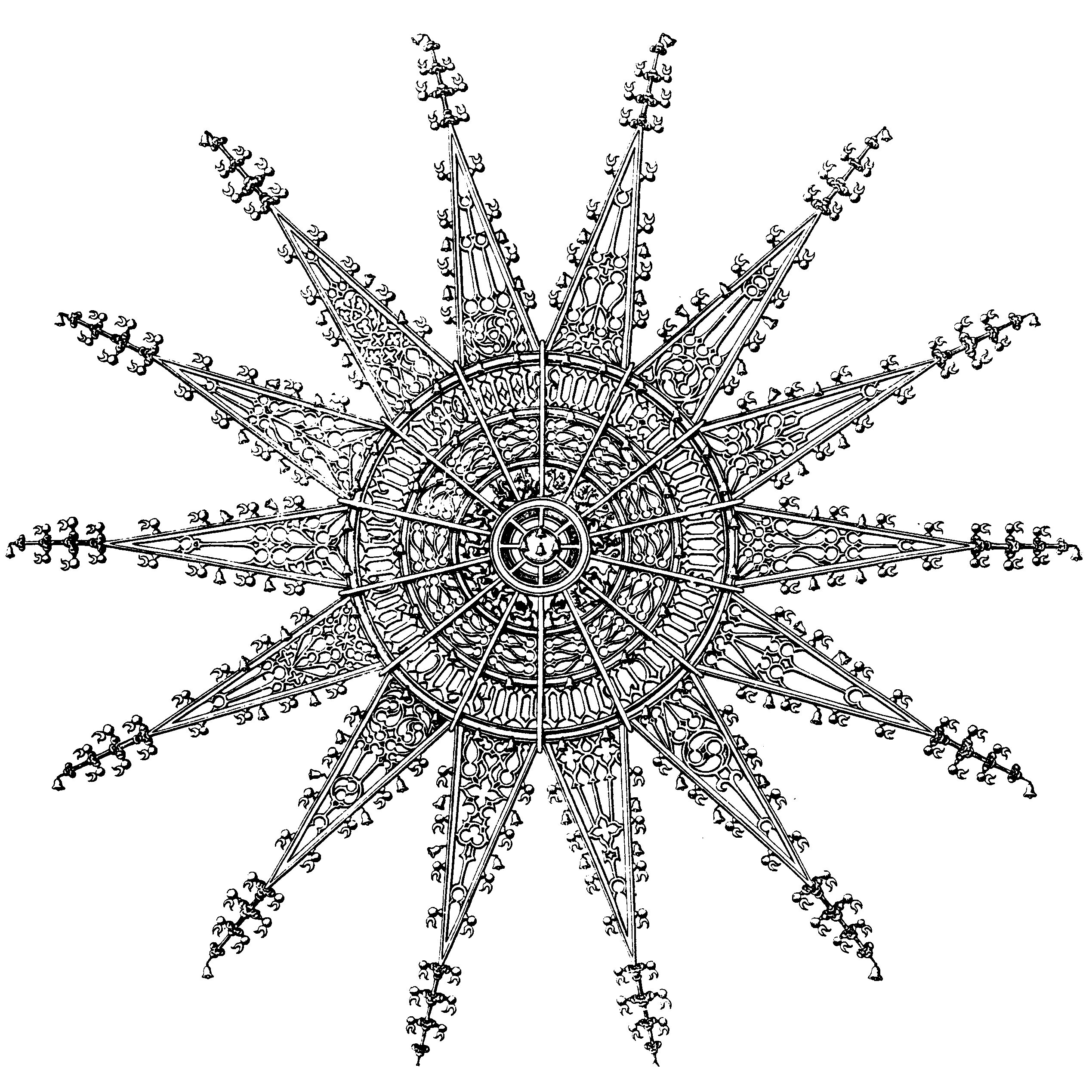Daniela Piana
In un saggio dai sapori non ortodossi, provocatori e gentili al contempo, qualche anno fa Alessandro Baricco scriveva: “quelli che chiamiamo barbari sono una specie nuova che ha le branchie dietro alle orecchie e ha deciso di vivere sott’acqua” (I Barbari, Milano, Feltrinelli, 2013). Sembra che questi “barbari” stiano proprio mutando la mappa.
Ogni sapere ha la sua grammatica, la sua pragmatica, la sua prossemica. Inclini a condividere l’intuizione di fondo che trapela da quelle parole, appare che siamo dinnanzi ad una frattura epistemologica prima che di carattere educativo e sociale.
Ancora Baricco: “una certa rivoluzione copernicana del sapere, per cui il valore di una idea, di una informazione, di un dato, è legato non principalmente alle sue caratteristiche intrinseche, ma alla sua storia. […] È come se il Senso, che per secoli è stato legato a un ideale di permanenza, solida e compiuta, si fosse andato a cercare un habitat diverso, sciogliendosi in una forma che è piuttosto movimento, struttura lunga, viaggio. Chiedersi cosa è una cosa significa chiedersi che strada ha fatto fuori di essa”. [p. 93].
Negli spazi lasciati liberi da ogni presidio di verifica e controllo si avventurano i “barbari” (che poi barbari non sono affatto) di Baricco, provocatoria immagine di una forma dell’essere esistenziale ed epistemico, sociale e pratico, che sta a sintesi ed evocazione di una matrice pensiero-parola con altra grammatica.
Ci sono lunghe stagioni nella storia umana in cui la grammatica, ormai formatisi, si utilizza, si applica e si declina nelle sue molte forme con variazioni su un tema dato. Lunghissimi archi di tempo e spazio dove costruire è possibile perché si condivide lo stesso compasso e si ha lo stesso metro di qualità. L’anima riposa in questo tempo, la mente alacremente si attiva in operose implementazioni di un paradigma dato.
I saperi fioriscono e così le professionalità che ne sono caratterizzate, ovvero che ne sono depositarie, riconosciute come loci indiscutibili di una conoscenza che non solo è padrona delle sue procedure di scoperta, ma anche di quelle di verifica e di validazione, così come di quelle di uso.
Se dal grand’angolo si scende nella mente locale, allora la compattezza dell’immagine si increspa già. Entriamo in un palazzo di giustizia. Il diritto è il sapere cardinale che segna ritmi e funzioni, che si offre come origine della grammatica con cui dire e ascoltare ciò che vi accade. Ma attorno a questo molti altri saperi co-partecipano della mente locale. L’antropologo Franco La Cecla ne tratteggia tutta l’essenziale ricchezza (Franco La Cecla, Mente locale, Milano, Elèuthera, 2021).
Facciamo un esempio. Le scienze che partecipano alla progettazione di una nozione urbanistica di una città, in primis le scienze dell’architettura e dell’ingegneria, sono basate in modo fondativo su una serie di presupposti epistemologici, e sono altresì foriere di griglie di lettura generali che mettono in relazione segmenti funzionali e variabili strutturali di quel sistema complesso che chiamiamo città. Ma per comprendere come si genera il senso del vivere urbano e come di fatto la cittadinanza si declina negli spazi reali e vissuti occorre andare nel contesto. Non è una geo-localizzazione. È una riflessione ed una osservazione dei rituali del vivere, che sono minuti, sovente silenziosi, e che sono densi di grammatiche multiple, dal comportamento del corpo, alle emozioni sociali, alla vastissima immaginazione intrisa di cultura iconografica, colori e ritmi dell’essere nella storia di quel luogo con quel portato mnestico.
I saperi che si aprono da momento fondativo a un momento di vertigine epistemologica sono il marchio di un’era che si proietta in un altro tempo senza ancora sapere cosa sarà.
In questo tempo storico che sta sul crinale di una profonda frattura, una delle forme del raccogliere e sintetizzare, per rendere governabile il complesso, è la ratio progettuale. Questo, tuttavia, non è il solito modo di fare progetti. Non si tratta solo, per quanto pertinente, di mettere in discussione come debba essere il futuro, con Marc Augé. Né, quindi, porci le domande sulle forze motivazionali necessarie per orientare l’azione in modo diverso da quella a cui la pandemia ci ha insegnato ad adattarci, cioè ad agire orientati a difenderci.
Il tempo storico in cui viviamo ci chiede di ascoltare anche la voce altra, di prendere sul serio le mutazioni che stanno aprendo delle faglie nei metodi con cui siamo abituati a validare le conoscenze cui facciamo appello per progettare le cose e per attuarne i progetti nei contesti. Affidarsi alla iper-proceduralizzazione e alla iper-standardizzazione appare una strategia desueta, poiché come Francesca Rigotti ci ricorda (L’era del singolo, Torino, Einaudi, 2021) la singolarità ci interpella e ci parla. La sfida sarà quella di non cadere nel relativismo dell’everything goes e al contempo di essere pronti a mettere in discussione le modalità di validazione dei saperi se esse non sono in grado di tenere conto della interdisciplinarità.
Insomma, questa volta siamo su un livello diverso rispetto alla “manutenzione di un paradigma” (Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 2° ed. 2009). Non ci imbarchiamo nel mantenimento di un paradigma che è ampiamente lavorato, implementato e infine ricevuto. Siamo esattamente sul canyon di un nuovo paradigma. Di conseguenza, ciò che tutti abbiamo di fronte è una frattura epistemologica.
Cosa questo comporti per il rapporto fra il diritto e la società si manifesta come epifania di una riqualificazione profonda del vivere civico. Il diritto è prima di ogni altra cosa una forma dell’essere nella storia con gli altri, improntato al primato delle regole rispettose della dignità della persona, supreme rispetto alla discrezionalità discriminante delle differenze individuali che sono il sostrato vitale della humanitas. Il diritto è, prima che scritto, vivente e lo deve essere se non lo si vuole declinare solo ed esclusivamente come atto di affermazione di una auctoritas depositaria di un potere normante e strutturante. Nondimeno, per vivere i rituali del diritto in azione, ossia di quella forma di agire non solo nel rispetto delle regole ma anche nell’orientamento dato e nella concretizzazione di un significato che trova nel diritto e nella categoria del dovere essere e del potere essere una radice collettiva – in quanto storicamente ancorata – occorrono apporti significativi che promanano da altre forme di grammatiche sapienti. Ecco da dove nasce la danza.
Proviamo a seguire l’idea di Calvino: “Ora, magnanimo Kublai, ti descriverò la città di Palmira, la sposa del deserto. Qui vi è un grande tempio di Baal, divinità dei Parti, preceduto da una grande via colonnata, un santuario di Nabu, l’Apollo mesopotamico, il teatro e le terme romane, il tempio di Baalshamin, venerato dalle tribù nomadi. Un circuito di mura racchiude tutta la città. Per millenni l’hanno attraversata i mercanti che con i loro cammelli scambiano le merci tra Roma e l’Oriente. Qui i viaggiatori si rinfrescano nelle acque sulfuree dell’oasi. La mattina un’attività frenetica si svolge intorno al mercato. A sera la città si riempie di luci, i fuochi illuminano le locande dove i mercanti, dopo aver reso omaggio all’ambiziosa regina Zenobia, consumano un ricco pasto tra musica e danze, e dove passeranno la notte tra lenzuola di seta […] La città dice dunque il suo passato e in esso si rispecchia un altrettanto inquietante futuro” (c.vo nostro).
C’è un diritto delle persone che si attaglia su Palmira, e ci sono rituali del vivere insieme. Quanto più le maglie delle grammatiche sapienti si aprono e gli spazi interstiziali fra un nesso sapiente e l’altro si rendono porosi, tanto più i sistemi conchiusi diventano dialoganti e le forme di sapere si mettono in relazione. Non è la vertigine del perdersi ma quella di pensare come essi si stiano mettendo in una dinamica di eco e di rimandi.
Ci sono molti contesti nel quali oggi il diritto appare vivere di un dialogo che induce a creare un senso attraverso la danza con altri saperi e con altri linguaggi. Già da tempo quelli della organizzazione, della psicologia, della gestione, dell’economia. Dopo quanto vissuto negli ultimi due anni è ancor più evidente che siamo dinnanzi ad un richiamo ineludibile ad un momento – forse lungo – di immaginazione di un mondo che si pensi nuovo, ma non con un atto fondativo istantaneo, piuttosto con un lungo percorso di esplorazione creazione immaginazione plurale.
Un percorso che deve essere visto nella sua pluralità a partire dall’apporto dei linguaggi delle arti. Se un nuovo si vuole, e lo si vuole migliore, allora occorre innanzitutto ragionarne nei termini che Musil avrebbe detto del pensiero del possibile. La realtà come una delle possibili forme con cui si dà l’epifania dell’essere. Non la sola. Un effetto di una congiuntura storica che si dà nella lunga durata e che avrebbe potuto prendere molte ed infinite traiettorie diverse. Ha preso quella che conosciamo e che chiamiamo storia.
Occorre immaginare che saperi diversi, anche per procedure di validazione del loro portato e di riconoscimento dei loro depositari, possano essere messi in relazione per rendere la legalità “diritto in azione”: al fine di vivere con mente locale e sguardo universale nella prassi quotidiana.
La ragione della Commissione di studio è qui. Le riflessioni qui proposte hanno un impatto profondo e di lunga durata sulla modalità con cui viene non solo prodotto ma anche trasmesso il sapere. Formare le menti, trasmettere conoscenza e riconoscere questa ultima nei loci in cui essa si genererà dalla danza di intelligenze e di saperi sarà la parte da costruire per chi intende l’apprendimento non come trasmissione ma come scoperta. Sviluppare teorie nella pratica, idee che generano sistemi de facto o quasi-sistemi in cui non hanno razionalità teoriche precedentemente sistemiche: sono le pratiche che rendono possibile questa produzione di conoscenza. Non pratiche idiosincratiche: piuttosto pratiche ripetute, condivise, che affondano le radici nelle aspettative degli altri di trovare la giornata secondo queste pratiche e di trarre da esse tracce di guida nell’azione. Le parole sono importanti, ma le speranze e le aspettative lo sono ancora di più in un periodo fortemente segnato da un cambio di paradigma. Un cambio di paradigma antropologico. Questa è la porta principale per cercare di trovare la strada sulla questione: dove attingiamo la conoscenza di cui abbiamo bisogno, per essere ispirati nella costruzione e trasmissione della conoscenza che non vediamo l’ora di attraversare da un paradigma all’altro?
Ecco, la Commissione incoraggia a muoversi fra e in quegli spazi aperti, delimitati ma non strutturalmente chiusi, che il Cais das Colunas mostra a Lisbona, laddove terra e acqua si uniscono. Pur vedendo colonne che delimitano allo sguardo un dentro ed un fuori, in verità è possibile comprendere ciò che quelle colonne significano più dall’acqua che fluisce che dalla terra che esse inquadrano fra l’una e l’altra.