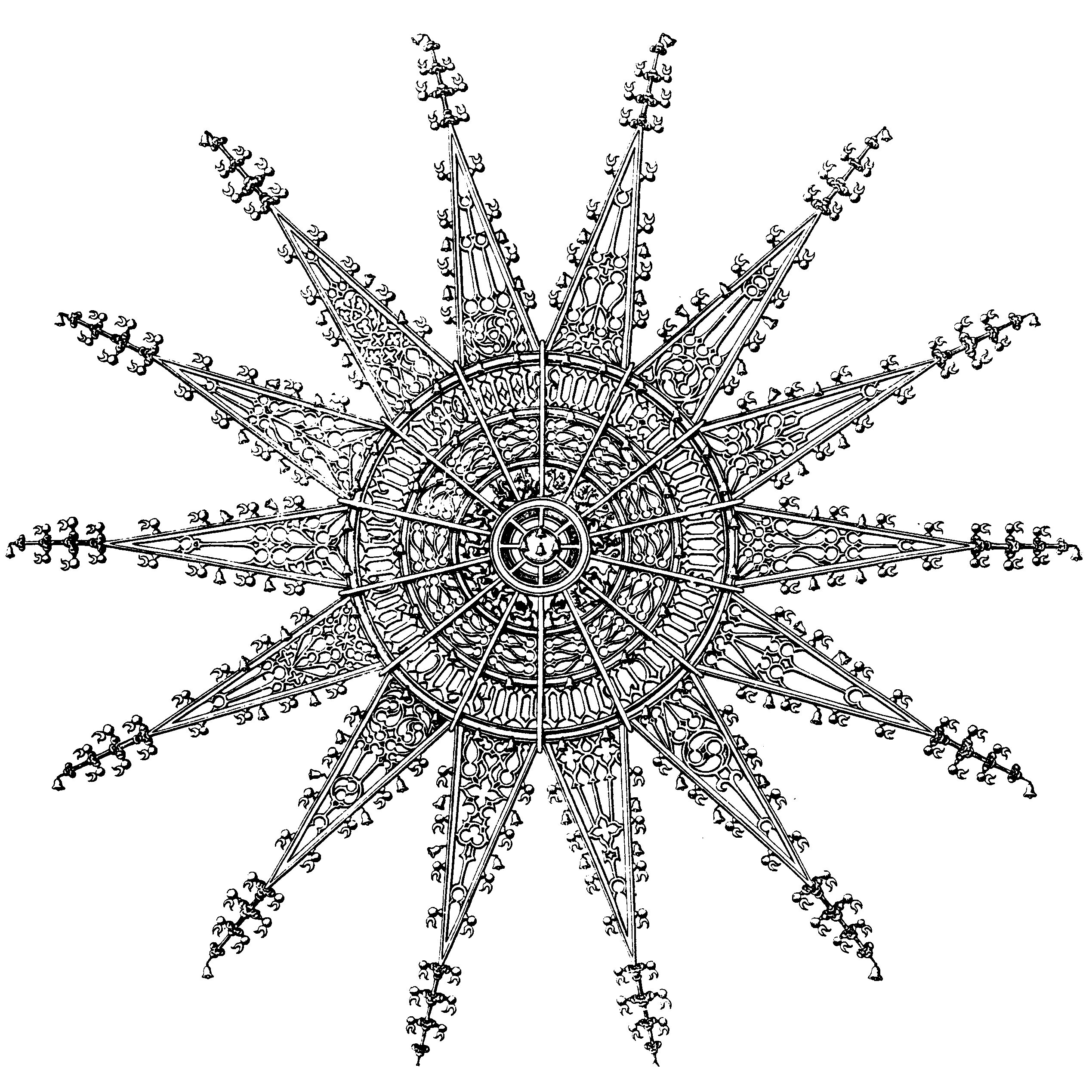Sono trascorsi quasi due secoli da quando, nel gennaio 1816, Madame de Staël in un famoso articolo apparso sulla «Biblioteca italiana» incitava gli italiani a «tradurre diligentemente assai delle recenti poesie tedesche e inglesi», convinta che l’esercizio della traduzione rappresentasse un mezzo formidabile per la trasmissione del sapere e il progresso culturale di un popolo.
Oggi come allora, si tratti di poesia, letteratura o saggistica, la traduzione ha il compito d’instaurare una relazione di equivalenza tra il testo d’origine e il testo tradotto, affinché il messaggio veicolato venga correttamente trasmesso e recepito.
Pare invece che certe volte la lingua d’arrivo, anziché favorire la trasmissione, costituisca una barriera, e non soltanto in àmbito musicologico. Scelte lessicali errate o imprecise, espressioni fraseologiche stereotipate o equivalenze di senso problematiche determinano spesso seri incidenti, se non addirittura gravi dissesti.
Ecco qualche minuscolo esempio. Per Chiara Briganti, che nel 1986 traduce per l’editore milanese Jaca Book l’importante monografia di Howard E. Smither, The Oratorio in the Baroque Era (1977), la locuzione «Italian opera libretto» troverebbe il suo equivalente in «libretto lirico italiano» (p. 31): così facendo, però, estende ingenuamente alla librettistica barocca un epiteto che in italiano è entrato in uso soltanto nel Novecento, nel sintagma ‘opera lirica’.
Ma c’è di peggio. Nell’impervia edizione italiana della monografia di Jörg Riedlbauer, Die Opern von Tommaso Trajetta (1994; Bari, Palomar, 2008), Antonella Gesmundo crea un ossimoro più scioccante che suggestivo: l’espressione «ruhig gehaltene Deklamation» (‘declamazione pacata, composta, mitigata’) si tramuta in «declamazione silente», dal senso a dir poco enigmatico (p. 138).
Ci sono poi le insidie della terminologia specialistica, la quale in musica si configura come un gergo tecnico piuttosto arcano, non accessibile ad ogni lettore. Ebbene, càpita a volte che la traduzione amplifichi tale estraneità fino all’incomprensibilità. Nel rendere in italiano Le Neveu de Rameau di Diderot, Mirella Brini Savorelli (Firenze, Leo S. Olschki, 2002) incorre in un “falso amico” mantenendo il genere femminile del sintagma francese «la basse fondamentale»: il ‘basso fondamentale’ teorizzato da Jean-Philippe Rameu diventa così – o piuttosto rimane – «la bassa fondamentale» (p. 31). Avrà inteso, la traduttrice, che cosa si nasconde dietro questo concetto, cui spetta un ruolo nevralgico nella polemica di Diderot e del suo interlocutore nei confronti dell’illustre zio?
Può succedere – lo sappiamo bene – che anche un traduttore provetto non sia padrone del vocabolario tecnico di una data disciplina; proprio per questo affidare la revisione dei testi a chi è specialista consentirebbe di evitare errori e fraintendimenti che travisano il senso, ostacolano o affaticano la lettura, e alla fin fine possono scoraggiare il fruitore, vanificando così il potenziale beneficio intellettuale del libro di partenza. Certo, lo specialismo del traduttore non può non sposarsi a un’ottima padronanza della lingua italiana e delle sue ricche risorse. Per dirla di nuovo con Madame de Staël (e sono parole attualissime): «gl’italiani dèono acquistar pregio dalle lettere e dalle arti; senza che giacerebbero in un sonno oscuro, d’onde neppur il sole potrebbe svegliarli».
Sara Elisa Stangalino
Dottore di ricerca
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna